Le maschere teatrali fecero la loro comparsa nell’Atene di V secolo a.C. dove, con l’introduzione delle rappresentazioni tragiche, comiche e satiresche, si svilupparono diverse tipologie di maschere. Esse venivano utilizzate dagli attori con funzione acustica -di amplificazione della voce- e scenica -di caratterizzazione dei personaggi-. Infatti un attore, dovendo interpretare più ruoli -anche femminili- aveva la necessità di indossare la maschera per poter impersonare al meglio un personaggio e, contemporaneamente, facilitare il riconoscimento dei diversi personaggi da parte degli spettatori.
Nel IV secolo a.C., accanto al tipo di satiro con barba nera fece la sua comparsa la maschera con i peli grigi e il tipo del satiro giovane imberbe[3]. In età ellenistica, la maschera satiresca ebbe un aspetto sempre più grottesco, in linea con le caratteristiche della Commedia Nuova, utilizzata in particolare per i tipi dello schiavo e del vecchio. Essi apparivano con fronte rugosa, sopracciglia notevolmente corrugate e sollevate, occhi sporgenti, naso camuso.
Oltre alla natura magica, la maschera cultuale poteva assumere inoltre funzione apotropaica: il carattere grottesco avrebbe aiutato a dominare gli spiriti della natura e a condizionare favorevolmente le loro azioni.
Il rinvenimento di maschere in marmo, terracotta o metallo, insieme allo studio delle fonti e dell’iconografia su affreschi e mosaici ha consentito di ipotizzare la composizione delle antiche maschere teatrali. Esse coprivano tutta la testa, costituite non soltanto dal volto ma anche da una parrucca. Il volto era ottenuto con tela di lino stuccata, legno o sughero dipinto; la parrucca, invece, veniva realizzata in pelo o lino[4].
Le maschere tragiche avrebbero avuto origine nella seconda metà del VI secolo a.C. Gli scrittori antichi attribuiscono a Tespi l’introduzione delle maschere negli spettacoli teatrali: durante le prime rappresentazioni tragiche, egli avrebbe fatto tingere il volto degli attori e, successivamente, fornito ad essi una maschera di tela inizialmente non dipinta. In seguito, Frinico cominciò a dipingerla con lo scopo di caratterizzare chiaramente il personaggio, utilizzando dunque il nero per i tipi maschili e il bianco per quelli femminili. Altri colori sarebbero stati introdotti da Eschilo che avrebbe, in tal modo, conferito alle maschere tragiche maggiore espressività[5].
Inizialmente, le maschere non avevano né bocca spalancata né sopracciglia prominenti, presentandosi piuttosto realistiche. Esse subirono un’evoluzione nel tempo che, tuttavia, non stravolse l’originario aspetto dei tipi, i quali però in età ellenistica divennero maggiormente caratterizzati e definiti, dalla spiccata tendenza al patetismo.
Attingendo probabilmente da una fonte ellenistica, Polluce (Onomastikon, IV, 133-154) individua ventotto tipi di maschere tragiche, quattro satiresche e quarantaquattro comiche[6]. Le tragiche e le comiche vengono divise in categorie. Tra le tragiche si contano sei gérontes (vecchi), otto neanískoi (giovani), tre therápontes (schiavi), undici gynáikes (donne) vecchie e giovani.
Polluce (Onomastikon, IV, 133-142) riconosce e suddivide le maschere tragiche come segue.
Gérontes (vecchi):
1. xyrías (il rasato): è il più anziano dei vecchi, dai capelli bianchi che aderiscono all’ónkos, guance rasate e cadenti;
2. leukós anér (l’uomo bianco): canuto, con le ciocche dei capelli che definiscono il capo, barba folta, sopracciglia inclinate, colorito biancastro, breve ónkos;
3. spartopólios (quello dai capelli grigi): capelli grigi, colorito piuttosto pallido;
4. mélas anér (l’uomo nero): barba e chiome ricciute, volto duro, grande ónkos e colorito scuro;
5. xanthós anér (l’uomo biondo): riccioli biondi, breve ónkos, volto ben colorito[7];
6. xanthóteros (quello ancora più biondo): simile al precedente ma più pallido, appare ammalato.
L’edificio teatrale coperto ad Atene: l’Odeion di Erode Attico.

La realizzazione del nuovo e maestoso odeion ebbe inizio nel 161 d.C. ma la data del termine dei lavori è alquanto incerta, compresa tra il 165 d.C. e l’anno in cui Pausania parla dell’edificio per la prima volta, ovvero il 174 d.C. La scelta del sito, ossia le pendici sud-ovest dell’Acropoli, identifica l’odeion come l’omologo dell’antico teatro di Dioniso Eleutherios (IV secolo a.C.) che sorgeva sulle pendici sud-est [3].
Nel 267 d.C. durante il sacco degli Eruli l’odeion di Erode Attico fu distrutto quasi integralmente da un incendio e mai più ricostruito. Agli inizi del XIX secolo, agli occhi dei viaggiatori e degli stessi cittadini ateniesi, le sue rovine inesplorate apparivano misteriose e di dubbia identificazione [4].
L’indagine del sito si deve alle campagne di scavo condotte dalla Greek Archaeological Society tra il 1848 e il 1958 [5]. Soltanto grazie ai restauri avviati nel 1954, poi, l’edificio ha riacquistato parte della sua originaria monumentalità e ancora oggi, durante la stagione estiva, ospita le manifestazioni musicali e artistiche del Festival di Atene.
Sia dal punto di vista architettonico che decorativo l’odeion rispecchiava le caratteristiche peculiari del teatro romano [6] e, al tempo stesso, eccelleva per l’originale elaborazione degli elementi stilistici dell’arte imperiale del II secolo d.C.
La cavea semicircolare, dal diametro di 76 metri, fu scavata nella roccia e poteva ospitare 5000 spettatori. Divisa in due settori orizzontali da un corridoio (diazoma) e circondata da un portico semicircolare, aveva sedili che si estendevano fin sopra le parodoi, rivestiti con il marmo bianco del monte Imetto. Oggi è completamente restaurata nelle parti mancanti. Al disotto della cavea, inoltre, esistevano dei passaggi sotterranei. Del portico semicircolare si conservano soltanto pochi resti murari alle spalle della cavea.
Anche l’orchestra, che ha un diametro di 19 metri, è stata ripavimentata negli anni Cinquanta del Novecento, con un’alternanza di lastre marmoree quadrangolari blu e bianche. Nell’originario piano pavimentale erano praticate delle aperture, probabilmente utilizzate per lo scolo delle acque piovane.
La parte più alta dell’edificio (ben 28 metri), che ancora si conserva quasi integralmente, è la parete che delimita la scaena. È costituita da una possente muratura (spessa 2,40 metri) in blocchi di poros con riempimenti di cementizio e mattoni. In origine doveva essere rivestita con lastre di marmo. La scaenae frons si articolava su tre livelli. Quello più basso, ovvero il fronte del podio scenico, mostrava un prospetto a tre porte arcuate ornato con colonne su alti piedistalli e piccole nicchie tra pilastri occupate da sculture. Di tale sontuosa decorazione marmorea, che forse comprendeva anche le statue delle Muse, oggi non resta nulla. Anche il podio rettangolare è stato restaurato in epoca moderna e continua ad essere utilizzato come base d’appoggio per un palcoscenico provvisorio. Ai suoi lati si sviluppavano i due parasceni, in origine estesi per l’intera lunghezza delle parodoi e oggi privi del piano più alto. Questi edifici laterali nascondevano sia dei corridoi per l’accesso alla summa cavea che alcune scale di collegamento ai livelli superiori della scaenae frons. La facciata dei lati interni dei parasceni, conservata per i primi due piani, continuava la decorazione del fronte del podio nella parte bassa e recava solo una nicchia in quella soprastante. Il secondo livello della scaena era strutturato con un’ampia nicchia centrale, in corrispondenza della sottostante porta mediana aperta sul podio, affiancata da aperture arcuate di minori dimensioni. Del piano più alto dell’edificio scenico restano soltanto alcuni archi di notevole ampiezza, meglio conservati nell’angolo sud-est del teatro.

Le origini del teatro greco si possono far risalire all’epoca della civiltà minoica. A Creta esisteva una gradinata rettilinea o un semplice prato erboso per gli spettatori, in un’area aperta, ma non delimitata, adibita allo spettacolo. A Lemno è attestata la prima struttura pre-teatrale conosciuta, quella di Poltochini, antica di circa tremila anni, che ha una costruzione rettangolare allungata. E tale doveva essere la struttura schematica ad Atene e Siracusa prima della costruzione dei teatri stabili in pietra, con una struttura quadrangolare, davanti la quale potevano essere collocate delle panche in legno per ospitare gli spettatori.
Il teatro di Atene, fu costruito nel temenos di Dioniso Eleutheros, sul fianco sud-est dell’acropoli. In quest’area sacra, di cui si possono approssimativamente segnare i limiti, vi erano anche due templi dedicati a Dioniso (Pausania 1, 20, 3).
Il teatro presenta varie fasi costruttive. La più antica è di VI sec. a.C., ed a questo periodo sembrano risalire pochi elementi strutturali, oltre ad un muro di contenimento. Nel 1886 (scavi di Dörpfeld), venne ritrovato un blocco poligonale di pietra calcarea proveniente dall’acropoli, sul quale era tracciato chiaramente un arco di cerchio. Inoltre si attestò la presenza, nella roccia viva, di un taglio a forma di arco di cerchio. Facendo passare una circonferenza per questi due archi, si ricostruì una antica orchestra, di circa ventiquattro metri di diametro, costruita prima delle guerra contro i Medi. Questa primordiale orchestra era situata obliquamente davanti al tempio di Dioniso, a una quindicina di metri dall’attuale spazio per le evoluzioni del coro. Intorno a quest’ultima, il koilon, con delle semplici assi in legno destinate ai posti a sedere per gli spettatori, e tali si manterranno anche nel V sec. a.C., almeno fino all’epoca di Sofocle e Aristofane, quando, a causa di un crollo (come attesta la Suda – Adler α 357, π 2230) si dovette provvedere alla costruzione di un theatron permanente con una gradinata in pietra (la parola theatron venne coniata per la prima volta dagli Ateniesi per indicare un teatro nel santuario di Dioniso Eleutereo).
A metà del V sec. il teatro aveva ancora una struttura mista di legno e pietra, che doveva apparire piuttosto precaria, la scena era in legno, come anche i sedili (ikria) e l’orchestra in terra battuta con al centro un piccolo altare circolare, detto thimele (Aristofane, Thesm. 395; Schol. ad. loc.; Libanio e Demostene 1,8).
Nel 330 a. C., durante l’amministrazione finanziaria di Atene ad opera di Licurgo, il teatro venne ricostruito in pietra.
Il koilon venne strutturato come un grande ferro di cavallo, prolungato alle estremità da due strutture rettilinee. Ad ovest ed a nord la curvatura si riduceva notevolmente, a causa della roccia dell’acropoli retrostante. Tutta la struttura era sostenuta e, nello stesso tempo rinforzata, da robusti muri di contenimento.
Nella parte superiore del koilon correva un diazoma piuttosto largo, sulla traccia dell’antico camminamento verso l’Asclepeion. E un tale corridoio è da ipotizzare anche per la parte inferiore. All’interno del koilon, erano i gradini in pietra calcarea, disposti in andamento discendente sul pendio, suddivisi in tredici cunei (kerkides). A nord-est era il cosiddetto monumento di Trasillo, luogo in cui erano esposti gli ex-voto e le iscrizioni di vittoria proprio sulla roccia viva (detta katatomé).
La fila di posti più vicina all’orchestra era occupata da sessantasette troni in marmo pentelico. Erano i posti di proedria, privilegio riservato a sacerdoti, efebi, generali. Al centro di essi era collocato il trono del sacerdote di Dioniso Eleutereo, riconoscibile tra gli altri per le magnifiche sculture.
L’orchestra era un semicerchio di circa venti metri di diametro; la sua circonferenza in quest’epoca, idealmente completata verso sud, verrà chiusa in epoca ellenistica dal proskenion in pietra. Intorno all’orchestra correva un canale concentrico, in pietra calcarea l’euripos, che doveva servire al deflusso dell’acqua piovana che scendeva dalla cavea. Polacco (1990) ha dimostrato che in origine questo canale era di forma esagonale, e divenne poi circolare (come anche tutto il teatro) durante la ristrutturazione Periclea, per migliorare l’acustica. Questo canale era scoperto, tranne che nei prolungamenti degli scalini; qui la comunicazione tra il koilon e l’orchestra avveniva attraverso delle placche in poros che formavano delle passerelle. L’orchestra del tempo di Licurgo non reca traccia di alcuna pavimentazione. La roccia naturale era semplicemente ricoperta di una sabbia argillosa e circondata da una bordura in pietra calcarea (ed è così anche ad Epidauro, a Megalopoli, a Eretria).
La scena di Licurgo si componeva essenzialmente di una lunga sala rettangolare, profonda circa sei metri e lunga una trentina, che ha alle sue due estremità due ali chiamate paraskenia (Dem. 520; I.G. II (2) 203 A 88) , larghe sette metri e sporgenti cinque. Probabilmente si intendeva riprodurre la facciata di una reggia di modello orientale. La maggior parte delle tragedie rappresentate si svolgono in contesti monarchici, le storie assumono così valenza paradigmatica. Inoltre le monarchie orientali erano le più ricche e potenti in cui il sovrano dettava legge, e rappresentavano la situazione politica del passato di Atene. L’unità di queste costruzioni, e dunque la loro datazione, è accertata in base al materiale usato per la costruzione, lo stesso di quello del koilon: blocchi di conglomerato per le sostruzioni, marmo bianco pentelico per le parti in elevato.
All’interno della grande sala, una fila di colonne sostenevano il pavimento superiore. I due paraskenia erano ornati ciascuno, nella parte interna, da nove colonne doriche. Tra i paraskenia e il muro anteriore della scena si estendeva un grande spazio libero, chiuso su tre lati e aperto davanti la scena. In questo spazio, in epoca ellenistica, si eleverà il proskenion in pietra, ma Dörpfeld ipotizza in quest’epoca l’esistenza di un proscenio in legno.
Tra i paraskenia e la cavea si aprivano le parodoi, le due entrate principali per gli attori in teatro e forse anche degli spettatori. Le parodoi sono parallele rispetto alla struttura della scena nel teatro di Atene e in quello di Siracusa.
All’estremità ovest del muro anteriore della skenè, una porta metteva in comunicazione questa con la parodos. Inoltre della scena di Licurgo faceva parte un portico addossato al suo lato posteriore. Questo era una sorta di decorazione architettonica e, nello stesso tempo, un riparo per gli spettatori in caso di pioggia, un luogo dove si poteva passeggiare comodamente, oppure un magazzino in cui venivano conservati strumenti scenici. Si tratta, tuttavia, soltanto di supposizioni in quanto non siamo in possesso di fonti (neanche epigrafiche) che spieghino la funzione specifica di questa struttura. Questo portico era un rettangolo lungo e stretto, chiuso su tre lati da mura e decorato con colonne sulla facciata.
La struttura del teatro così costruita rimase quasi invariata nel corso dei secoli successivi, subendo pochi interventi in epoca romana. L’orchestra ha subito profonde alterazioni al tempo di Nerone, verso il 60 a. C., quando venne ricoperta da una pavimentazione in marmo, con una grande losanga centrale. Inoltre venne costruita una barriera in marmo alta quasi un metro, che doveva servire per combattimenti gladiatori e altri giochi simili. Un’altra alterazione subì la skenè durante il II o il I sec. a. C., con la costruzione di un proskenion permanente in pietra e di un logheion sempre in pietra. Nella cavea l’intervento di Nerone si limitò ad aggiungere seggi di proedria, che vennero inoltre spostati più in alto.
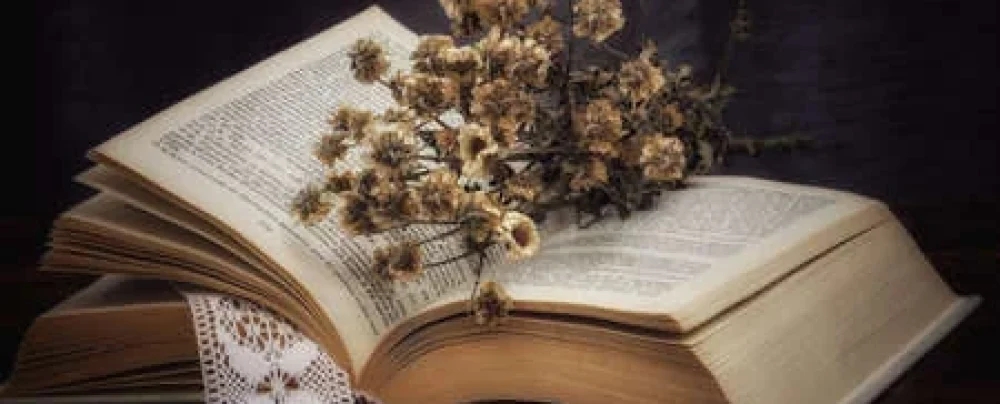
Buongiorno sono Aurora una studentessa dell’Università di Trento, sto iniziando a scrivere una tesi sulla maschera nell’antica Grecia e come poi essa viene ripresa nel ‘900 da alcuni pittori e vorrei chiederle gentilmente se ha una bibliografia inerente a questo suo scritto. Grazie.
"Mi piace""Mi piace"
occorre sapere la bibliografia,
cortesemente può indicarla? grazie.
"Mi piace""Mi piace"
Buon pomeriggio Attenomis
a questo link che le incollo troverà una soddisfacente bibliografia
http://www.treccani.it/enciclopedia/maschera_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/
Grazie
Buon pomeriggio
"Mi piace"Piace a 1 persona
Pingback: Gli alieni di “Arrival”, il linguaggio ed una critica al sentimentalismo | IlPiccoloMetafisico
Complimenti per il post scritto in modo esaustivo e completo
Ti seguirò con piacere
Adriana Pitacco
"Mi piace"Piace a 1 persona
la ringrazio Adriana
"Mi piace""Mi piace"