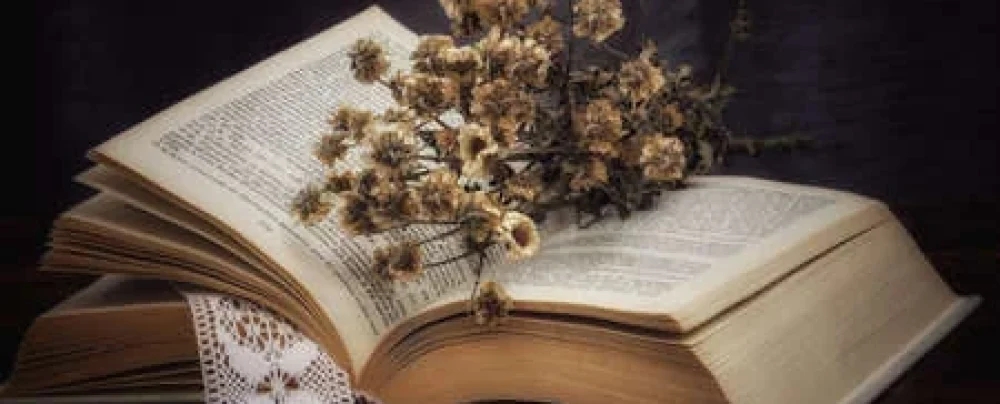La parola carnevale deriva dal latino “carnem levare” (= eliminare la carne) e originariamente indicava il banchetto che si teneva l’ultimo giorno del Carnevale (Mardi Gras), immediatamente prima della quaresima, il periodo di digiuno e astinenza in cui i cristiani si sarebbero astenuti dal carne. Le prime prove dell’uso della parola “carnevale” (o “carnevalo”) sono i testi del menestrello Matazone da Caligano del tardo XIII secolo e dello scrittore Giovanni Sercambi intorno al 1400.
Periodo di Carnevale
Nei paesi cattolici, tradizionalmente il Carnevale inizia la domenica di Settuagesima (70 giorni a Pasqua, era la prima delle nove domeniche prima della Settimana Santa nel calendario gregoriano), e nel rito romano termina il martedì prima del mercoledì delle ceneri, che segna l’inizio della Quaresima Il climax è di solito da giovedì a martedì, l’ultimo giorno di Carnevale. Essendo collegato con la Pasqua che è una festa mobile, le date finali del Carnevale variano ogni anno, anche se in alcuni luoghi può iniziare già il 17 gennaio. Dal momento che la Pasqua cattolica è la domenica dopo il primo plenilunio di primavera, quindi dal 22 marzo al 25 aprile, e dal momento che ci sono 46 giorni tra il mercoledì delle ceneri e la Pasqua, poi negli anni non bisestili l’ultimo giorno di Carnevale, Mardi Gras, può cadere in qualsiasi momento entro il 3 febbraio al 9 marzo.Nel rito ambrosiano, seguito nell’Arcidiocesi di Milano e in alcune diocesi limitrofe, la Quaresima inizia con la prima domenica di Quaresima, quindi l’ultimo giorno di Carnevale è sabato, quattro giorni dopo il Mardi Gras in altre zone d’Italia .

Pieter Paul Rubens (1577-1640), Bacchanal auf Andros (1635), da un disegno di Tiziano, Nationalmuseum är Sveriges, Stoccolma
Carnevale nell’antichità
Sebbene presente nella tradizione cattolica, il Carnevale ha le sue origini in celebrazioni molto più antiche, come le feste greche dionisiache (“Anthesteria”) o il “Saturnalia” romano. Durante questi antichi riti si verificava una temporanea dissoluzione degli obblighi sociali e delle gerarchie a favore del caos, delle battute e persino della dissolutezza. Dal punto di vista storico e religioso, il Carnevale rappresentava, quindi, un periodo di rinnovamento, quando il caos sostituì l’ordine stabilito, ma una volta terminato il periodo festivo, un nuovo o vecchio ordine riemerse per un altro ciclo fino al prossimo carnevale.A Babilonia , poco dopo l’equinozio primaverile, il processo di fondazione del cosmo fu rievocato, descritto con il mito della lotta di Marduk, il dio salvatore con Tiamat il drago, che si concluse con la vittoria del primo. Durante queste cerimonie si è svolta una processione in cui le forze del caos venivano rappresentate allegoricamente combattendo la ricreazione dell’universo, cioè il mito della morte e risurrezione di Marduk, il salvatore. Nella parata c’era una nave su ruote dove le divinità Luna e Sole erano trasportate lungo un grande viale – un simbolo dello Zodiaco – al santuario di Babilonia, simbolo della terra. Questo periodo è stato accompagnato da una libertà sfrenata e un’inversione di ordine sociale e moralità.
Nel mondo romano la festa in onore della dea egizia Iside coinvolse la presenza di gruppi mascherati, come racconta Lucio Apuleio nelle Metamorfosi (libro XI). Tra i Romani la fine del vecchio anno era rappresentata da un uomo coperto di pelli di capra, portato in processione, colpito con bastoni e chiamato Mamurius Veturius.
Il carnevale è quindi un momento in un ciclo mitico, è il movimento degli spiriti tra cielo, terra e mondo sotterraneo. In primavera, quando la terra inizia a mostrare il suo potere, il Carnevale apre un passaggio tra la terra e gli inferi, le cui anime devono essere onorate e per un breve periodo i viventi prestano loro i loro corpi indossando maschere. Le maschere quindi hanno spesso un significato apotropaico, in quanto chi lo indossa assume i tratti dello spirito rappresentato.
Nei secoli XV e XVI, i Medici a Firenze organizzarono grandi carri mascherati chiamati “Trionfi” accompagnati da canti carnevaleschi e danze, il “Trionfo di Bacco e Arianna” anch’esso scritto da Lorenzo il Magnifico. A Roma, sotto i Papi, si svolsero le corse dei cavalli e fu chiamata la “corsa dei moccoletti” dove i corridori con le candele accese provarono a spegnere le candele l’uno dell’altro.

Influenze africane sulle tradizioni carnevalesche
Importanti per le arti dei festival caraibici sono le antiche tradizioni africane di sfilare e muoversi nei circoli attraverso villaggi in costume e maschere. Si pensava che i villaggi circolanti portassero fortuna, per curare i problemi e rilassare i parenti arrabbiati che erano morti e passati nell’altro mondo. Le tradizioni carnevalesche prendono in prestito anche dalla tradizione africana di mettere insieme oggetti naturali (ossa, erbe, perline, conchiglie, tessuto) per creare un pezzo di scultura, una maschera o un costume – con ogni oggetto o combinazione di oggetti che rappresentano una certa idea o spirituale vigore.
Le piume venivano spesso usate dagli africani nella loro madrepatria con maschere e copricapo come simbolo della nostra capacità di superare problemi, dolori, crepacuore, malattie per viaggiare in un altro mondo per rinascere e crescere spiritualmente. Oggi vediamo piume utilizzate in molte, molte forme nella creazione di costumi di carnevale.
La danza africana e le tradizioni musicali hanno trasformato le prime celebrazioni del carnevale nelle Americhe, mentre ritmi di tamburo africani, grandi pupazzi, combattenti con bastoni e ballerini hanno iniziato a fare le loro apparizioni nelle feste carnevalesche.
In molte parti del mondo, dove gli europei cattolici fondarono colonie ed entrarono nella tratta degli schiavi, il carnevale attecchì. Il Brasile, una volta colonia portoghese, è famoso per il suo carnevale, così come il Mardi Gras in Louisiana (dove gli afro-americani mischiavano con i coloni francesi e i nativi americani). Le celebrazioni del Carnevale si trovano ora nei Caraibi a Barbados, Giamaica, Grenada, Dominica, Haiti, Cuba, St. Thomas, St. Marten; in America centrale e meridionale in Belize, Panama, Brasile; e nelle grandi città del Canada e degli Stati Uniti dove si sono stabiliti i Caraibi, tra cui Brooklyn, Miami e Toronto. Anche San Francisco ha un carnevale!
L’essenza delle celebrazioni del Carnevale, nelle loro manifestazioni di eccesso e di lasciarsi andare, contrasta con l’umore della Quaresima in cui le questioni dello spirito superano l’importanza delle cose del mondo.
Un’origine alternativa coinvolge il festival romano Navigium Isidis (nave di Iside). In questa festa tradizionale, l’immagine di Iside fu portata in processione fino alla riva per benedire l’inizio della stagione della vela. La processione comprendeva maschere elaborate e una barca di legno che veniva anche trasportata. Queste caratteristiche potrebbero essere i precursori della tradizione carnevalesca moderna che coinvolgono carri allegorici e maschere.
La connessione etimologica con quest’ultima teoria si basa sul termine carrus , che significa auto, al contrario di carne . Il festival menzionato sopra era conosciuto con il termine latino carrus navalis . Va notato, tuttavia, che questo festival è stato associato a entrambe le stagioni agricole (che si svolgono appena prima dell’inizio della primavera) e alla sessualità. Di conseguenza, è anche possibile che quando il festival divenne cristianizzato qualche tempo dopo, questi due aspetti furono semplicemente sostituiti da carne vale , un inizio più appropriato alla Quaresima.
Prima che il carnevale fosse slegato dal calendario liturgico, era una parola cristiana, o più precisamente cattolica. Il carnevale e le forme correlate in altre lingue hanno fatto storicamente riferimento alle feste spesso rauche che culminano nel giorno prima dell’inizio della Quaresima, noto come martedì grasso o martedì grasso ( Mardi Gras in francese).
Poiché la quaresima consiste nel rinunciare alla carne, è facile vedere la connessione con la parola latina per carne o carne: caro ( carnis nel caso genitivo), che ci dà anche carnale , carnivoro e altre parole carnose. Una spiegazione popolare è stata che il tempo del carnevale è quando si dice “addio alla carne”, o carne vale , con la valle che rappresenta un saluto latino (letteralmente “sii forte” o “sii buono”).
La spiegazione del carne vale molti secoli fa. Il dizionario italiano-inglese 1611 di John Florio, il nuovo mondo di parole della regina Anna , definisce la parola italiana carnevale come il tempo in cui “la carne è addio addio”. Due secoli dopo, Lord Byron ha dato la stessa etimologia nel suo poema esteso del 1817, Beppo: A Venetian Story , che si svolge durante il carnevale a Venezia:
Questa festa è chiamata il Carnevale, che essendo
Interpretato, implica “addio alla carne”:
Così chiamato, perché il nome e la cosa concordano,
Attraverso la Quaresima vivono di pesce, sia salato che fresco.
Ma “addio alla carne” è in realtà un’etimologia popolare senza basi storiche. Gli etimologi indicano i primi usi registrati della parola nei dialetti dell’Italia settentrionale dal 12 ° secolo, dove compaiono le forme carnelevale o carnelevare . Sulla base di questa evidenza, sembrerebbe che il termine sia nato dalla frase latina carnem levare , o “togliere la carne”, che poi divenne carnelevare in italiano antico, poi carnelevale , poi carnevale per omissione di una sillaba (conosciuta come Aplologia).
Ma alcuni studiosi dell’Europa medievale pensano che anche questo rappresenti un’etimologia popolare, prendendo una parola preesistente per una festa e dandole una lucentezza cristiana. Il principale sostenitore di questa teoria è lo storico francese Philippe Walter, il cui libro Mythologie Chrétienne , tradotto in inglese come mitologia cristiana , postula che la parola carnevale precede il cristianesimo e fu razionalizzata come “togliere la carne” per cristianizzare i rituali pagani.
I rituali su cui Walter si concentra hanno a che fare con una figura mitica conosciuta come Carna. Secondo gli scribi romani come Ovidio, Carna era una dea alla quale veniva dato un sacrificio di fagioli e carne grassa, in particolare maiale. Si può vedere nelle successive celebrazioni del carnevale un focus non solo sui cibi ricchi e grassi (come nel martedì grasso), ma anche sui rituali che coinvolgono i fagioli. La torta del re , ad esempio, in origine era una torta in cui era nascosto un fagiolo, con il cercatore del fagiolo chiamato “re della festa”. (Più di recente, l’oggetto nascosto è stato una statuetta di porcellana o plastica.)
Per quanto riguarda l’ elemento val , Walter suggerisce una connessione alla festa di San Valentino di metà febbraio. Molto prima che il giorno di San Valentino fosse celebrato romanticamente con carte e cioccolatini, il 14 febbraio era una data sul calendario cristiano per commemorare il martirio di San Valentino. Come sottolinea Walter, Valentino rappresenta in realtà non meno di cinque diverse figure sante del cristianesimo primitivo, e vede che come prova che il giorno della festa era destinato a camuffare una celebrazione pagana più antica, forse coinvolgendo quella val di sillaba.
Potete trovare molto di più su questo nel primo capitolo del libro di Walter, intitolato ” Carnival, The Enigma of a Name “. Anche se può essere nient’altro che congetture condivise, è affascinante pensare che il nostro carnevale contemporaneo debba le sue origini a una figura che Walter denota deliziosamente “la dea del maiale e dei fagioli”.